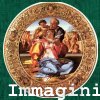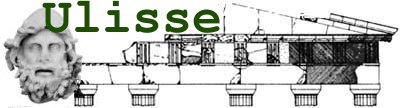
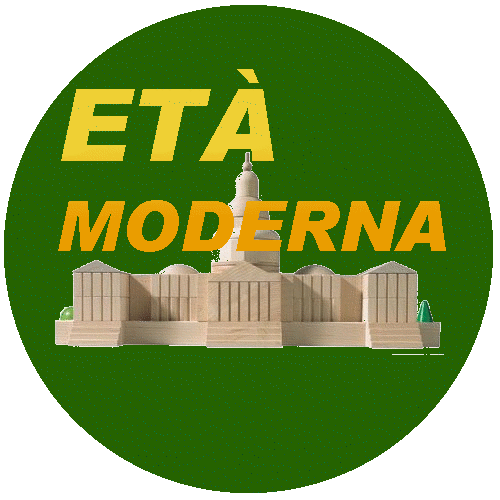
Suoni su Ulisse dall'Età Moderna: il Ritorno di Ulisse in patria di MonteverdiClaudio MonteverdiClaudio Monteverdi (Cremona, 15 maggio 1567 - Venezia, 29 novembre 1643) fu un compositore, violinista e cantante italiano. 
Il suo lavoro segna il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca. Nel corso della sua lunga vita ha prodotto opere che possono essere classificate in entrambe le categorie, e fu uno dei principali innovatori che portarono al cambio di stile. Monteverdi scrisse la prima opera teatrale realizzabile, L'Orfeo, e fu abbastanza fortunato da godere del successo mentre era in vita. Nel 1590 Monteverdi iniziò a lavorare alla corte di Mantova come corista e violinista, e per il 1602 era diventato direttore d'orchestra. Fino ali suo quarantesimo compleanno lavorò principalmente su dei madrigali, componendo in tutto otto libri. Il libro VIII, pubblicato nel 1638, comprende i cosidetti Madrigali guerrieri et amorosi che molti considerano come la perfezione di questa forma. Nel loro insieme, i primi otto libri di madrigali mostrano un enorme sviluppo dalla musica polifonica rinascimentale allo stile monodico che è tipico della musica barocca. Il nono libro di madrigali, pubblicato postumo nel 1651, contiene brani più leggeri, probabilmente composti nell'arco della sua vita, che rappresentano entrambi gli stili. Nel 1613 viene nominato direttore a San Marco, Venezia, dove ben presto fece rinascere il coro, che era avvizzito sotto il suo predecessore. Qui egli completò il sesto, settimo e ottavo libro di madrigali. L'ottavo è il più grande, e contiene lavori scritti in un periodo di 30 anni, compresa la scena drammatica Tancredi e Clorinda (1624), nella quale l'orchestra e le voci formano due entità separate, che agiscono come copia una dell'altra. Probabilmente Monteverdi fu ispirato a provare questo arrangiamento a causa delle due balconate opposte di San Marco, che avevano ispirato musica simile ad altri compositori, come Giovanni Gabrieli. Ciò che fece spiccare questa composizione sulle altre, è il primo utilizzo del tremolo (una veloce ripetizione dello stesso tono) e del pizzicato (pizzicare le corde con le dita) per ottenere effetti speciali nelle scene drammatiche. Durante gli ultimi anni di esistenza Monteverdi si ammalò, ma ciò non lo tenne lontano dalla composizione dei suoi due ultimi capolavori, entrambi opere: Il ritorno di Ulisse in patria (1641), e l'opera storica l'Incoronazione di Poppea (1642). L'Incoronazione in particolare, è considerata il punto culminante del lavoro di Monteverdi. Essa contiene scene tragiche e comiche (un nuovo sviluppo dell'opera), un ritratto più realistico dei personaggi, e delle melodie più calde, che non si erano sentite prima. Richiedeva un'orchestra più piccola, e un ruolo meno prominente del coro. Questo lavoro ebbe anche una considerevole influenza sullo sviluppo della musica per chiesa (messe). Monteverdi compose almeno diciotto opere, delle quali solo l'Orfeo, l'Incoronazione, Il ritorno, e la famosa aria "Lamento", dalla sua seconda opera l'Arianna, sono sopravvissute. Per trovare più informazioni su Monteverdi, vai su www.haendel.it/compositori/monteverdi.htm Il ritorno di Ulisse in patriaCerto è che Monteverdi non trascurò di buttarsi, alla veneranda età di 72 anni, nella nuova grande impresa commercial-musicale che proprio in quegli anni muoveva i primi passi nella Serenissima Repubblica: il teatro musicale a pagamento, non più per corti e palazzi, ma per luoghi appositi dove il pubblico doveva pagare, in varie forme, per entrare. Questi luoghi a Venezia si chiamavano il San Moisè, che fu inaugurato nel 1639 con una replica di Arianna, il San Cassiano, per il quale compose ex novo Il ritorno d’Ulisse in patria nel carnevale 1640. 
Il ritorno d’Ulisse in patria fu dunque composto nell’epoca in cui il teatro perdeva la caratteristica di svago riservato ai nobili per aprire le proprie porte a tutti coloro che fossero in grado di pagare il biglietto. È il periodo in cui nasce il teatro in musica, e in cui poesia e strumenti, canto e melodia si incontrano per dare vita ad una nuova forma artistica. In Inghilterra sono gli anni del Grande Bardo, William Shakespeare, e il parallelo non poteva sfuggire ad un regista “shakespeariano” come Adrian Noble: la costruzione drammaturgica delle contrapposizioni, il sottile equilibrio fra tragedia e commedia, la caratterizzazione dei personaggi sono tutti elementi – sottolineati da questo allestimento – che legano il capolavoro monteverdiano all’universo shakespeariano. 
Anche “da un punto di vista vocale l’Ulisse prevede una caratterizzazione estrema dei personaggi, alcuni dei quali, come Minerva, sono chiamati a prove veramente virtuosistiche. Si può anzi dire che proprio da qui il virtuosismo vocale diviene parte integrante dello spettacolo d’opera. Quest’opera costituisce per i cantanti una prova difficile, perché si devono continuamente confrontare con la grande precisione ritmica di Monteverdi, ma, nello stesso tempo, devono ricercare la libertà del canto. Le immagini che vedi si riferiscono alla messa in scena dell'opera al teatro Alighieri di Ravenna l'11 e il 13 febbraio 2005 dalla "Accademia Bizantina" diretta da Ottavio Dantone e dal Coro "Costanzo Porta" col maestro Antonio Greco. Tra i protagonisti Sonia Prina (Penelope), Furio Zanasi (Ulisse), Roberta Invernizzi (Minerva). |