A supporto della fede nell'esistenza in un Essere Supremo un fondamentale argomento, difficilmente contestabile anche dagli atei, è costituito dall'esistenza, in diverse cultura, di un diffuso quanto vario sentimento religioso.
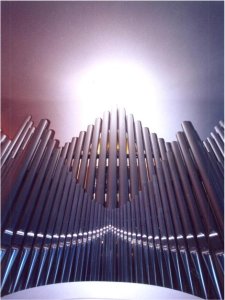
Si può dunque sospettare che quest'ultimo non rappresenti solo un prodotto culturale, ma venga da un intimo ed innato afflato religioso.
L'Accademia fa proprie le osservazioni di chi ritiene che i riti e le speculazioni teoretiche costringano tale afflato, e spesso, dandogli forma, lo deformano. Ritiene dunque che per recuperare l'essenza e l'autenticità del sentimento religioso interiore dell'uomo sia necessario ripudiare le forme intellettualistiche di riflessione sul Divino, e su se stessi.
In quest'ottica, sono più vicini al divino quanti sono più lontani dall'intellettualismo, e da quanto si definisce, nella lingua internazionale, come mindwork.
Tutti i filologi con coscienza metodologica, tutti gli psicanalisti di se stessi, tutti gli ansiosi, gli uomini e le donne profonde, i "thoughtful citizens" [1], tutti quanti danno una qualunque forma di consenso informato a una cosa qualunque, sono lontanissimi dal divino [2].
I membri dell'Accademia sono dunque, in linea di principio, molto poco divini [3]. Tuttavia, attraverso un percorso di progressivo ripudio della loro zavorra mentale, essi cercano di accostarsi progressivamente alla condizione divina.
Icona esemplare di quest'ultima è Epifanio di Salamina, patriarca nella Chiesa dell'Impero Romano d'Oriente, tra i protagonisti, ormai in età avanzata, del Sinodo della Quercia a Costantinopoli all'inizio del IV sec. a.C., per cui valga la definizione del prof. Sever J. Voicu, Responsabile della sezione greca dei papiri della Biblioteca Vaticana (Roma): "Un centenario completamente rimbambito" (Conferenza "La patristica nella Bibliotheca di Fozio", 19 aprile 2005, Università di Palermo).
[1] Tutti e trentacinque quelli rimasti in Italia, senza dimenticare gli undici statunitensi.
[2] E' chiaro il riferimento alla innata divinità interna agli inconsapevoli animali, che partecipano della natura divina del tutto all'interno delle concezioni animistiche e panteistiche. Non meno scontato è il riferimento all'idea, così diffusa tra le culture religiose antiche e moderne, dello speciale rapporto col divino del folle, dell'invasato, del semplice. Non estranea a tutto ciò è la primitiva visione francescana della mancanza di dottrina come via privilegiata per l'esperienza religiosa. Va però aggiunto che taluni alti membri nonché fondatori di Codesta Accademia dissentono tale lettura della figura di Francesco di Assisi, che ritengono il frutto di un perverso incrocio tra spiritualità sessantottina, cinematografia di Zeffirelli (con musiche di Baglioni) ed attivismo cattolico. Tali membri dissenzienti ammirano Francesco e lo ritengono impegnato sulla strada verso Dio, ma ricordano che chi fa penitenza non può essere Dio. Talvolta i membri dissenzienti possono sembrare molto cattivi.
[3] Vd. l'articolo 4 dello Statuto dell'Accademia dello Gnappo